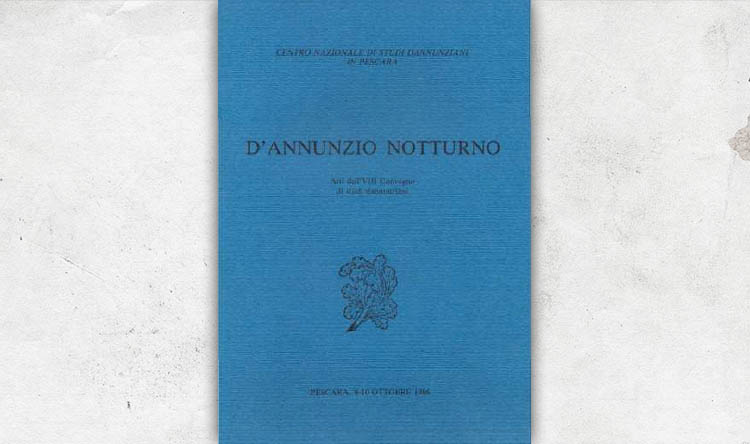Atti dell' VIII Convegno, 8-10 ottobre 1986
• Premessa di Ettore Paratore •
Ricordo la gigantesca propaganda di Notturno al tempo della mia adolescenza. Abitavo a Urbino e venivo a Roma durante le vacanze. Sul finire del 1921 la pubblicazione del nuovo libro di D'Annunzio era accompagnata a Roma da un meccanismo pubblicitario veramente eccezionale. Lungo tutto il Corso aggeggi piantati sui palazzi l'uno di contro all'altro sostenevano fili da cui pendevano striscioni su cui era stampato il nome della nuova opera. Fino a piazza Colonna la principale strada di Roma non faceva che moltiplicare alla vista di tutti il titolo Notturno. E la stampa propagandistica infuriante sui giornali, nei manifesti, negli estratti pubblicitari presentava il volume come novità stupefacente della tecnica dannunziana.
In realtà si trattava di un unicum nella produzione del divo Gabriele. Fino a un decennio prima i suoi scritti in prosa erano stati novelle e romanzi. La tendenza a un tipo di prosa che si staccasse dall'impianto romanzesco s'era insinuata negli articoli autobiografici pubblicati nel Corriere della Sera, che poi sarebbero stati raccolti nel Venturiero senza ventura; la Contemplazione della morte nel 1912 aveva offerto un primo specimen di prosa non narrativa, la Leda senza cigno aveva presentato un vago schema di romanzo cui la Licenza successivamente composta aveva sovrapposto pagine di più libera e sradicata fantasia. C'erano stati quindi i segni di una svolta verso una prosa che dissolvesse gli spunti narrativi in un ritmo liricamente fantastico costituente un trait d'union fra racconto e poesia. Del resto sin dal primo romanzo, Il Piacere, s'era manifestato lo sforzo d'affrancamento dalla rigorosa struttura romanzesca, di convergenza verso lo studio, sostanzialmente autobiografico, della psiche del protagonista; sin d'allora emergeva la spinta a quell'ideale "libro di prosa" che, come il D'Annunzio dice, "essendo vario di suoni e di ritmi come un poema, riunendo nel suo stile le più diverse virtù della parola scritta", si proponga "non imitare ma continuare la Natura". Questo libro era stato finalmente composto col Notturno, che veramente sollevava l'"esplorazione d'ombra" alla sottigliezza lirica più evanescente, faceva naufragare ogni spunto narrativo in una reviviscenza emotiva totalmente personale. Il D'Annunzio notturno (e non è un caso che a definirlo funzioni l'aggettivo corrispondente al titolo del volume) non è stato mai così integralmente tale come nell'opera del 1921: basta un confronto con Il compagno dagli occhi senza cigli, Il secondo amante di Lucrezia Buti, Le cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto, Solus ad solam.
Che i cartigli su cui, dopo l'incidente che nel gennaio 1916 lo privò dell'occhio destro, l'autore scrisse "questo comentario delle tenebre" siano veramente esistiti e su di essi il D'Annunzio abbia steso la sua prosa rigo per rigo lo conferma il fatto decisivo ch'essi sono conservati al Vittoriale. L'Annotazione finale del volume dice la verità, che cioè, una volta rimessosi in piedi l'autore e voltosi a quanto aveva vergato durante la degenza, parecchie di quelle liste non erano più decifrabili né da lui né dalla figlia Renata sì che egli dovette ricomporre non poche pagine. Sospettiamo che il numero di quelle rifatte sia maggiore di quanto Gabriele ci vuol far credere, anche perché i frequenti incontri fra il testo di Notturno e i Taccuini denunciano contatti che non potevano certo verificarsi mentre il poeta conduceva faticosamente, quasi cieco, il lapis sulla carta delle liste e documentano un più pacato raccoglimento dell'autore su tutto quanto aveva scritto a proposito dei particolari illustrati nella prosa notturna.
Il Leitmotiv delle 494 pagine1 è, fino al momento del conclusivo ritorno alla deambulazione, lo stato tormentoso in cui l'autore si trova steso e quasi immobilizzato sul letto, con l'occhio fasciato e sottoposto a continui interventi medici, con le braccia serrate sui fianchi, con la testa a livello leggermente inferiore a quello dei ginocchi, con una sete insaziabile aggravata dal parco uso dell'acqua imposto da chi lo curava. I motivi estranei che si accavallano a questa disperatamente descritta condizione o sono pretesti di cui l'autore va in cerca per distrarsi dalla sua sofferenza o sono ricordi che proprio il dolore rievoca in connessione con lo strazio presente. Perciò l'elemento narrativo ch'essi contengono si sfarina nel continuo richiamo che l'autore fa alla tormentosa condizione in cui si trova. Un episodio che fa veramente eccezione è quello della morte del compagno di volo Giuseppe Miraglia, di cui l'autore, con singolare costanza d'impegno narrativo, racconta tutto: l'appuntamento preso col compagno per un volo, l'improvviso annuncio dell'incidente fatale, la precipitosa corsa verso la salma, la lunga veglia funebre con un'infinità di particolari determinanti la scena, i funerali col discorso cui il poeta non s'è potuto sottrarre, la sepoltura. Ha forse voluto il poeta creare un doppione di quello ch'egli augurava per sé nel momento dello sconforto? Certo il motivo, ritornando a p. 338, finisce per costituire un pilone dello svolgimento lirico. Lo conferma il fatto che s'affollano motivi analoghi di allusioni ad altri compagni o a scene di guerra come l'impresa di Oreste Salomone del bombardamento di Lubiana che s'insinua più saltellante e ritorna a p. 483 e persino nell'Annotazione, come il ricordo dei discorsi tenuti a Roma nel maggio 1915 per esortare all'intervento, come quello delle battaglie di Francia, come la scena dei soldati ciechi, come l'operazione di sbarramento con le torpedini sul lido di Panzano, che assume un andamento narrativo simile a quello della morte di Miraglia, come la visita di Umberto Cagni, l'altro largo squarcio del bombardamento dei marinai, la morte di Bresciani e di Prunas, il singolare evento dell'aviatore e dei delfini, il fantastico motivo finale dell'eroico contadino che, richiesto dai nemici d'indicare il guado del fiume, s'incammina per esso, ma poi s'abbassa e si lascia sommergere per far credere ai persecutori che anche lì non c'è guado. Il bello è che, come i particolari sovrapposti di questo tipo cominciano proprio col ricordo dell'incidente di volo che è costato un occhio al poeta, così essi ricorrono anche, con uguale tecnica, nell'Annotazione, che dovrebbe seguire altro procedimento e che invece prolunga quello dei giorni di letto. Vi si trovano il ricordo dell'incursione su Rovigno e delle altre imprese belliche, quelle della morte di Garrone, e il brano su Aquileia, che coll'episodio del soldato miserabile che si mette a pescare crea un pendant all'episodio del contadino al guado, che non per niente torna ad essere ricordato in queste pagine.
L'Annotazione, col ricordo della morte della madre e le impressioni che ne sono suscitate, svolge anzi un tema di fondo dell'accensione lirica già emerso nelle pagine precedenti, in cui della madre si parla con trepidante commozione, associandone la memoria a quella della casa paterna e ritornandovi a p. 363. Il motivo della madre è il vertice delle digressioni più tipicamente liriche in cui si squaderna la sensibilità sempre in tensione del poeta cui l'immobilità a letto scatena per reazione una valanga di legami col mondo prima vissuto e golosamente goduto. Ed ecco la visione del vecchio scultore Gemito ottenebrato dalla follia, il brano tanto ammirato delle violette di Pisa, il rifugio verso il mondo della musica in cui campeggiano Gerolamo Frescobaldi, il trio degli spettri di Beethoven e i preludi di Scriabin ispiranti sofisticate variazioni in versi adoperate anche a p. 328 sgg. e a p. 355-36, dove, a farci conscii dell'assidua presenza del furore guerriero tutt'altro che spento dalla disavventura, rispunta il motivo del "sole / che mai vide alcuna cosa più grande / di Roma". E ancora la fine rievocazione delle dolcezze della Versilia, quella dell'incendio nelle Lande di Arcachon, i passeggeri tocchi su Cherubino di Mozart, su Michelangelo operante nella Sistina, le pagine sul creatore e compratore di strumenti musicali, il nostalgico pensiero sul giovanile amore fiorentino per Giselda Zucconi2 e finalmente la lunga variazione sulle accumulantisi sensazioni da giovedì santo a Pasqua (p. es. la descrizione del sonno di Renata) e il delizioso squarcio sui cavalli, dal trasvolatore El-Nar in Egitto al povero Aquilino nella fanciullezza.
Questo ansimante rovesciarsi di ricordi, di aneliti, di sfoghi psichici vorrebbe essere il debordare improvviso di tutto quanto il poeta non aveva ancora espresso di sé, di tutta la pletora di sensazioni e di sentimenti che costituiva il suo intimo più profondo da cui le opere precedenti erano scaturite. Perciò di queste quasi nulla è citato nel volume con sorpresa del lettore, che da tutto questo complesso di memorie s'attendeva che molto ne sgorgasse anche dei libri già composti. E invece possiamo annoverare solo il richiamo al verso Come vien l'acqua al cavo della mano nel brano della madre, il nome di Sirenetta dato alla figlia Renata con derivazione dalla Gioconda, il ricordo di Giorgio Aurispa e quello di Malatestino della Francesca a p. 215 ("Come il mio selvaggio Malatestino, dirò 'Io vedo pur con l'uno' "). Ma questo verso qui addotto sta ad assicurarci che proprio quando lamenta la sua condizione di recluso nell'immobilità e di colpito in uno degli organi più vitali e se ne dispera, il D'Annunzio non ha rinunciato a nessuno dei suoi princïpi fondamentali. Ogni tanto un tocco esplodente sul più bello ci fa avvertire che 1'Uebermensh è ancora vivo e nell'intimo contraddice alla desolata lamentazione da cui il volume è nutrito e modellato. Un motivo anch'esso dominante e conforme alla predominante desolazione è quel che di mucido, di vischioso erompe dalla natura smortamente acquea di Venezia. Ma la Venezia del Fuoco e della Nave finisce per fare da sfondo all'opera quando essa prorompe in frasi come quella di p. 150: "Ero quel che sono quando la mia natura e la mia cultura, la mia sensualità e la mia intelligenza cessano di lottare e si conciliano compiutamente. Ero un mistero musicale con in bocca il sapore del mondo". E così si mediti quanto è scritto a p. 229: "Questa è la mia magia. Nel dolore e nelle tenebre, invece di diventar più vecchio, io divento sempre più giovine... Scopro nelle cose una qualità fisica nuova. Sento in tutto quel che tocco, in tutto quel che odo, una novità ammirabile". Non altrimenti a p. 267 ("La vita non è un'astrazione di aspetti e di eventi, ma è una specie di sensualità diffusa, una conoscenza offerta a tutti i sensi, una sostanza buona da fiutare, da palpare, da mangiare. Io sento tutte le cose prossime ai miei sensi. Nulla sfugge agli occhi senza tregua attentissimi che la natura mi ha dati, e tutto m'è alimento e aumento. Una tal sete di vivere è simile al bisogno di morire e di eternarsi") e a p. 296 ("Chi non teme la morte, non muore. E la morte non vuole chi la cerca").
Si scopre cioè che tutta l'irta descrizione di uno stato tormentoso è una prova vittoriosa che il multanime autore sfoggia delle sue capacità di resistenza e di rivalsa. Di qui anche la maestria nel consegnare al dettato un'andatura spezzata, filiforme, ossessivamente iterativa che materializza l'espediente di scrivere rigo per rigo sopra un cartiglio stretto e prolungato, la padronanza ostentata di un nuovo stile in cui l'avvicendarsi di tocchi staccati fa prevalere il ritmo scandito, agglutinante attraverso forti pause un particolare all'altro. Si noti a p. 54:
"Il bacino di San Marco, azzurro.
Il cielo da per tutto.
Stupore, disperazione.
Il velo immobile delle lacrime.
Silenzio.
Il battito del motore.
Ecco i Giardini.
Si volta nel canale".
E ancora più caratteristicamente a p. 221:
"Ascolto.
Lo sciacquìo alla riva lasciato dal battello che passa,
I colpi sordi dell'onda contro la pietra grommosa.
Le grida rauche dei gabbiani, i loro scrosci chiocci, le loro risse stridenti,
le loro pause galleggianti.
Il battito di un motore manno.
Il chioccolìo sciocco del merlo.
Il ronzìo lùgubre d'una mosca che si leva e si posa.
Il ticchettìo del pendolo che lega tutti gli intervalli.
La gocciola che cade nella vasca del bagno.
Il gemito del remo nello scalmo.
Le voci umane nel traghetto.
Il rastrello su la ghiaia del giardino.
Il pianto d'un bimbo non racconsolato.
Una voce di donna che parla e non s'intende".
A variare, c'è poi un periodo più sciolto e complesso con un'ipotassi funzionante da ripresa nettamente aggiuntiva.
Questa prestigiosa capacità innovatrice trova più che mai sfogo nella scelta dei vocaboli. Il materiale lessicale ci presenta un largo numero di parole che o sono rare o addirittura non sono registrate in nessun dizionario. Tra queste, elenco: "amatizzato, arteficiato, chierici a, cinga (sost.), i gomita, idrottero, incarbonito, insonnio, mescolo (sost.), resiniere, scarpella, sclera, sgrigiola, tagliamare, tentoni (sost.), velma". Accanto a queste un nugolo di parole che i dizionari ospitano come voci desuete, e che spesso sono forme rare accanto ad altre consimili e più usate, come p. es. sguittire invece di squittire. Leggendo Notturno arriviamo al punto di constatare che la nostra non è una buona conoscenza della lingua. Si prenda p. es. un passo a p. 23: "Scrivo come chi caluma l'ancora, e la gomena scorre sempre più rapida, e il mare sembra senza fondo, e la marra non giunge mai a mordere nè la gomena a tesarsi". La prosa giunge a cantare ai limiti dell'intelligibilità nel sapientissimo sfogo lirico che ci offre un'opera scritta quasi per scommessa nella sfida di esprimere un mondo senza alcuno schermo narrativo, attraverso la magia di un ambiguo, ondulante melodiare.
NOTE
1. Faccio sempre riferimento al volume della casa Treves in cui Notturno uscì stampato per la prima volta nel 1921 con le xilografie di Adolfo De Carolis; di esso seguo anche la numerazione delle pagine.
2. Si tenga presente che proprio da questo ricordo Giselda si sentì incoraggiata a chiedere al D'Annunzio, proprio nel 1921, il permesso di pubblicare una serie di sue lettere.